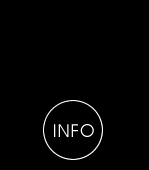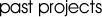Elio Grazioli interviene sul tema della mostra 'Strutture precarie'
Conferenza tenutasi il 16 ottobre 2009 presso la Fondazione Ado Furlan di Pordenone
Non viaggio molto, ma ogni volta che torno dalla Francia tormento i miei amici perché là vedo sempre delle mostre realizzate secondo un modo che mi non mi pare di vedere altrove. Quale modo? Semplicemente con un'idea, nel migliore dei casi anche un'ambizione culturale più generale e di conseguenza anche l'ambizione di intervenire sull'esporre stesso. Non parlo necessariamente di grandi mostre come Les Immatériaux, che fu probabilmente la prima, nel 1984, progettata e curata nientemeno che da Jean-François Lyotard, ma anche le varie che mi è capitato di vedere alla Villa Arson di Nizza alla fine degli anni ottanta, intorno a quel gruppo di lavoro composto da Philippe Parreno, Dominique Gonzalez-Foester e compagnia internazionale, come No man's time, del 1991; o quelle all'Arc di Parigi, come L'Hiver de l'amour, nel 1994, o Traversées, nel 2001, o Voilà le monde dans la tête, nel 2002; per non parlare delle più impegnative L'Informe, del 1996, fino alla recente Airs de Paris, due anni fa. Ma anche altre, sia chiaro, anche fuori Francia, come la leggendaria De la catastrophe, a Ginevra già nel 1982. In Italia non riesco a ricordarne di simili.
Mostre non necessariamente costose, spesso anzi con cataloghi fatti in economia, ma tutte mostre pensate, condivise, da cui usciva una riflessione utile per tutti. Mostre che si aprivano ai contributi più vari, di volta in volta invitando studiosi di varie discipline, poi facendoli collaborare con gli artisti, poi ancora facendo uscire tutti dagli spazi istituzionali, costringendoli a confrontarsi direttamente con il pubblico, insomma seguendo le necessità del momento, aggiustando il tiro, sperimentando aspetti inediti. Mai esposizioni fini a se stesse, sempre, almeno nelle intenzioni, messe alla prova del dibattito ampiamente culturale.
Due anni fa la rivista "Fresh Théorie" ha dedicato un numero a questo argomento proponendo una definizione di queste esposizioni come "manifestazioni", ovvero "esposizioni di e del pensiero". Mi sembra chiaro ed efficace.
Gli esempi più recenti, ancora francesi, sono per me le esposizioni degli ultimi anni al Palais de Tokyo. Si vede già dall'allestimento, che naturalmente conta tantissimo. Vi si respira un'aria che si capisce subito che si tratta di qualcosa di diverso. E' importante che sia così, è ciò che chiamiamo "senso contemporaneo", cioè il fare i conti con il continuo cambiamento in atto. Si ha subito l'impressione che vi si elabora una visione della cultura, che si tenta di darne un'altra immagine. Qui in particolare sono in gioco, tema attuale del dibattito artistico, le cosiddette "utopie", cioè le vie che la storia ha interrotto, per vari motivi di ogni tipo, ma che possono tornare e contenere spunti assolutamente riproponibili e punti di partenza per nuove strade alternative o trascurate. E parliamo non di stili artistici, ma di scienza, comportamenti, culture locali, ipotesi sociali, esperimenti in ogni campo.
Si comprende bene che non sono progetti improvvisati e che sono frutto di un'équipe che li ha condivisi. Gli stessi artisti, solitamente restii a prestarsi a interpretazioni tagliate su misura, evidentemente comprendono di farne parte, non di esserne sopraffatti. Evidentemente sono anche artisti "diversi", appunto.
E io? La mia esperienza è che davvero in Italia non si è fatto niente del genere e non si riesce a farlo. Si vede che interessa troppe poche persone. Le esposizioni sono più pubblicitarie o illustrative. Non sono esse stesse parte del dibattito, un dibattito fatto attraverso mostre. Salvo iniziative sparse e periferiche, come la vostra. Anche in questo caso grazie a un gruppetto di persone che lo vogliono fare e si spendono per farlo.
Io non ho avuto la fortuna di trovare una situazione simile e posso portare la testimonianza solo di un percorso individuale. Credevo di avere trovato una situazione condivisa alla fine degli anni ottanta, con una generazione di artisti più giovani di me di una decina d'anni, di cui mi interessava molto il lavoro e il modo di fare. Con loro ho in effetti realizzato un piccolo gruppo di mostre che timidamente andavano in una direzione di qualcosa di condiviso. Si sono intitolate Passioni, a Parigi nel 1990; Teatro degli interni, al Castello di Rivara nello stesso anno; poi, l'anno seguente, Una scena emergente al Museo Pecci di Prato, per non parlare di cose ancora più timide e piccole sparse in gallerie private un po' ovunque. Ma non ha funzionato, per tante ragioni, perché non c'era niente di veramente condiviso.
Ne venni fuori, confesso, piuttosto disilluso e deluso. Feci una mostra allo spazio Viafarini di Milano in cui chiusi le opere di una quarantina di artisti in scatole di cartone, rendendole non visibili. Le si poteva vedere solo acquistandole, "a scatola chiusa", che era appunto il titolo.
Poi per molto tempo non curai più mostre se non personali o scrivendo per cataloghi su richiesta. Mi dedicai all'editoria, dove si possono fare cose diverse. Non mi dilungo su questo. Voglio solo chiudere quel che mi riguarda facendo riferimento a due esposizioni che mostrano il punto a cui sono e la mia proposta in questo contesto.
La prima era intitolata Collezionismi, realizzata due anni fa, ad Assab One, a Milano. Quello che voglio far notare è come l'allestimento diceva già l'essenziale: il collezionare inteso come un modo di stare al mondo, come una pratica che è la costruzione di un sapere e di un fare contemporanei. La mostra nasce da un piccolo libro che ho curato su questo tema, intitolato Il collezionismo o il mondo come voluttà e simulazione. Voglio dire che quello che si vede subito è che l'arte è sullo stesso piano di altri oggetti, che dunque il tema è un altro, il collezionare come investimento sì, ma di una pulsione.
La seconda e ultima era intitolata Immagine la vita, tenutasi allo Spazio Gerra, a Reggio Emilia, l'anno scorso. Anche qui si è trattato di mettere l'arte a confronto con altro, in particolare con queste famose altre "immagini" da cui diciamo di essere frastornati, senza veramente, a me pare, farvi i conti. Qui l'allestimento è discreto e solo allusivo: suggerisce un ambiente domestico, con piante e poltrone e tappeti, salvo che sono in disordine, ovvero se ci siede non si è di fronte a un'opera, le piante sono un po' in mezzo ai piedi, eccetera. Sui tavoli ci sono dei computer e dei video sintonizzati su siti e programmi televisivi selezionati, alle pareti, oltre a "opere d'arte" ci sono manifesti pubblicitari e quant'altro. Il tema qui è l'immagine e, come ribadisco, i conti che l'opera d'arte deve farci, il ruolo e la differenza che deve affermare. Il titolo della mostra suggerisce che il problema, evidentemente, è il suo rapporto con la vita, meglio direi, come riesce ad essere metafora della vita e di che tipo di vita vuole essere la metafora.
Credo che c'entri con la precarietà, no? Ma veniamo dunque a Palinsesti. Innanzitutto noto con curiosità che dopo un'edizione dedicata sostanzialmente alla postproduzione ne venga una dedicata alle "strutture precarie". Già questo meriterebbe una quantità di riflessioni. Sintetizzo così: nei tempi della postproduzione, ripensamento della precarietà non come sentimento di smarrimento e di non durata – a proposito: non è che mi avete invitato perché l'edizione di quest'anno di "Fotografia Europea", una manifestazione che curo a Reggio Emilia, era all'insegna della "eternità"?! – dunque, dicevamo, non instabilità, come però dice l'unica definizione riporta in catalogo, ma sintesi da ricercare con l'autonomia e la progettualità della "struttura". Mi pare che – recuperando in questo senso non tanto la postproduzione quanto i nodi e la rete dell'edizione precedente – qui si sia optato per un progetto, una struttura diciamo così "dolce", liquida, dinamica, basata su rapporti-reciprocità che si costruiscono di mano in mano che subentra un nuovo elemento, un nuovo interagente. Questa dinamica mi interessa molto, era di fatto l'argomento del mio libro sul collezionare: come si sceglie un elemento e come esso ristruttura l'insieme in cui entra? cosa determinerà la scelta successiva? esistono una ragione originaria e un fine di questa attività e di questo insieme? La collezione è a sua volta un'opera, stavolta del collezionista, fatta dell'insieme delle opere che contiene?
Lo stesso si può chiedere e dire dell'esposizione. Non per niente la sequenza degli interventi comincia con il rovesciamento (Anne Mette Hol) di ciò che il progetto potrebbe somigliare: non si tratta di "site specific" in senso proprio; ovvero: la "site specificity" si costruisce su se stessa, di mano in mano, facendosi, risultando dalla sequenza degli interventi; non è in partenza, ma alla fine. Per questo insistevamo all'inizio sul fatto che essa non debba essere un semplice allestimento, ma che a sua volta si presenti come riflessione estetica sulla propria "struttura", appunto, fino a dire che lo stesso si può affermare dell'arte stessa. L'arte è una "struttura precaria", anzi è "la" struttura precaria, è il pensiero e il fare basati positivamente su tale dialettica. In fondo, azzardo io, la vita stessa lo è: ciò che in essa strutturiamo, progettiamo, controlliamo, istituzionalizziamo, automatizziamo, razionalizziamo, è solo una parte necessaria di tale dinamica.
Questo accenno alla vita lo faccio non per esasperare il discorso, ma, al contrario, perché quello che mi colpisce e piace più di tutto di questa mostra – e in genere, confesso, di ogni mostra – è l'atmosfera, la sensazione che mi dà di come viene vissuta la vita da chi la realizza, artisti, curatori, tutti quelli che ne hanno condiviso la realizzazione.
L'atmosfera di questa edizione di Palinsesti a me piace, mi sembra reale e umana, pensata e frutto di una ricerca e di espressione di un modo di essere e di stare.
E' a questo proposito che voglio eventualmente dire qualcosa delle opere degli artisti partecipanti, gran parte dei quali non conoscevo e che vedo per la prima volta. Ebbene, innanzitutto non c'è affermazione perentoria né di una forma né di un contenuto dato per certo e paradigmatico. C'è invece molto rimando al privato, al personale, al biografico a volte, che dice quanto le forme siano vissute, e come vadano verificate sul conto della loro realtà concreta piuttosto che dei loro principi e della loro oggettività. C'è la presa in carico dei piccoli scarti, delle differenze minime ma essenziali, degli errori che svelano e muovono la struttura verso esiti imprevisti e più vivi (Manya Kato). C'è perfino in rimando alle "controculture" (Dora Economou), che sono gli "scarti" a livello dell'ufficialità della cultura dominante. C'è l'elenco in progress di Emanuele Becheri, che probabilmente tematizza la struttura precaria più di ogni altro intervento dell'esposizione.
Se in questa parte della manifestazione i curatori hanno innescato il processo di "reciprocità" lasciandolo poi in mano agli artisti stessi, che hanno interagito tra di loro in fase progettuale e allestitiva, nella parte dedicata ai video è il curatore che ha imposto non solo la scelta delle opere già esistenti, ma soprattutto lo schema di interazione mettendoli tutti nella stessa grande stanza, sufficientemente distanziati perché si possano fruire anche singolarmente, ma suggerendo fin a livello allestitivo appunto come l'interazione si crea e quanto essa sia illuminante di aspetti inediti dei video stessi, attraverso l'effetto degli accostamenti, sovrapposizioni dei sonori, salti e scarti, cioè, com'è chiaro, attraverso quegli stessi dispositivi che sono tematizzati dalle opere stesse. Per questa ragione, confesso, questa è la parte che ho preferito, perché più criticamente evidente, se così posso dire.
Infine – ma in realtà già durante la sua realizzazione – l'esposizione è diventata a sua volta matrice produttrice di altre opere e di altre mostre, quelle dei fotografi Alessandro Ruzzier e Luca Laureati, che vanno ben oltre la pura documentazione, come se, giustamente, la sequenza dovesse, si auspicasse di continuare, non di chiudersi su se stessa ma al contrario: di "uscire" ed espandersi.
Questo lavoro fotografico è stato inoltre lo spunto per un discorso a parte sulla fotografia. Fa bene Roberto Del Grande a ricordare nel suo testo in catalogo in particolare il bellissimo libro di Jean Marie Schaeffer intitolato proprio L'immagine precaria, una lettura indimenticabile. A sua volta fuori dagli schemi formalisti a base semiologica – icona o indice? entrambe? in che senso? – o di altro tipo – fotografia documentaria o artistica? o che altro? – Schaeffer ricorda nel suo libro che la peculiarità della fotografia in quanto immagine è la sua precarietà, il suo saper catturare la precarietà ma anche il suo essere volutamente l'immagine della precarietà, l'immagine di un'atmosfera e del farsi, ma al contempo del ritornare dell'immagine nella dimensione dell'invisibile, della sparizione… Ricorderò sempre quello che Schaeffer scrive delle fotografie di Bernard Plossu, che metto a conclusione anche di questo mio intervento: "è l'anima ad essere sfocata", cioè è la fotografia ad essere come la vita, non la vita come la fotografia.
Artisti
Ex Essiccatoi
- Emanuele Becheri
- Dora Economou
- Ane Mette Hol
- Manya Kato
- Deborah Ligorio
- Eléna Nemkova
- Chris Oakley
- Giulia Piscitelli
- Semiconductor
Fondazione Furlan (PN)
Alessandro Ruzzier
immagini e suoni che documentano il processoEx Mercato pesce (UD)
Luca Laureati
foto documentazioneCuratori
Denis Viva
(Ex Essiccatoi)
Roberto Del Grande
(Alessandro Ruzzier, Luca Laureati)